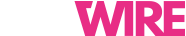David Foster Wallace, scrittore e saggista, autore di libri fenomenali come “Considera l’aragosta“, proprio con quella narrazione ci invitava a prendere in considerazione l’aragosta, creatura viva gettata nell’acqua bollente per il nostro piacere gastronomico. Oggi però la scienza ci spinge ad andare oltre, molto oltre, fino a considerare esseri infinitamente più piccoli e apparentemente insignificanti: le mosche, le api, le formiche. Da una domanda scomoda – gli insetti provano dolore? – nasce un interrogativo ancora più inquietante: se la risposta fosse affermativa, dovremmo cambiare il nostro rapporto con loro?
La questione ha smesso di essere puramente filosofica per entrare i laboratori, dove emergono prove sempre più difficili da ignorare. Se gli insetti sentono male, vuol dire che sono coscienti. E questo potrebbe spostare il confine della considerazione della vita “superiore” ancora più in basso nella scala evolutiva di quanto pensassimo e fossimo pronti ad accettare.
La mosca che scelse di morire
Un team di ricercatori coreani ha creato mosche transgeniche dotate di recettori umani del dolore, portando a risultati sconcertanti. Quando a queste mosche è stato offerto del cibo contenente capsaicina (la sostanza che rende piccanti i peperoncini) hanno manifestato reazioni sorprendentemente simili a quelle umane. Non solo fuggivano, ma si strofinavano freneticamente le parti buccali con le zampe, in un comportamento che sembra inequivocabilmente una risposta al dolore. Più impressionante ancora, questi insetti hanno preferito morire di fame piuttosto che consumare quel cibo, anche dopo 18 ore di digiuno. Quale meccanismo, se non un’esperienza negativa consapevole, potrebbe spiegare un comportamento così estremo?
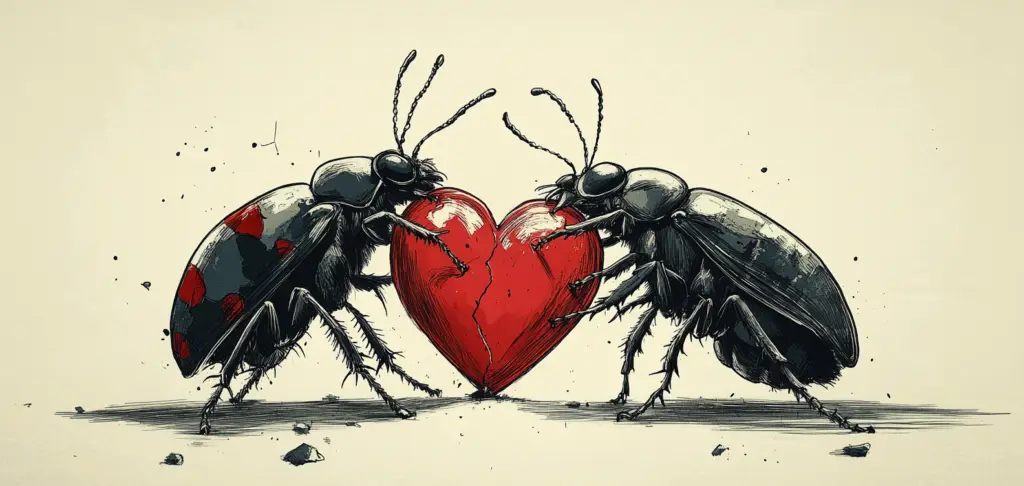
Certo, stiamo parlando di insetti modificati geneticamente, non di quelli comuni. Ma le ricerche si allargano: studi hanno dimostrato che analgesici umani come il gabapentin e l’ibuprofene modificano le risposte degli insetti agli stimoli dolorosi. Le mosche a cui viene rimossa una zampa diventano più sensibili al calore, un fenomeno noto come allodinia neuropatica, simile a quello che accade negli umani dopo lesioni nervose. Sorprendentemente, le stesse mosche vengono usate come modello per testare farmaci contro il dolore destinati agli esseri umani, un paradosso che dice molto sulla nostra incoerenza.
Cervelli minuscoli, capacità sorprendenti
Non ci pensiamo, di solito, ma pregiudizi, modi di dire, meme, sono tutte cose che risiedono in fondo alla nostra mente ma influenzano in modo molto attivo il modo con cui vediamo il mondo e la vita. Ad esempio, “Cervello di una mosca” è un’espressione che usiamo per indicare scarsa intelligenza, ma la scienza sta demolendo questo luogo comune relativo più o meno tutti gli insetti. Le api possiedono concetti astratti come “uguale” e “diverso”, apprendono osservando i loro simili e alcune specie usano persino strumenti rudimentali. I recenti studi del FlyWire Connectome hanno rivelato che il cervello della Drosophila, la comune mosca della frutta, ha un livello di integrazione e connessione neurale molto più complesso di quanto si pensasse. Gli insetti non sono semplici automi guidati da risposte programmate, ma esseri capaci di adattamento, apprendimento e, potenzialmente, esperienze soggettive.
Se pensate che tutto questo ci dovrebbe dare da pensare, non siete i primi e non siete soli. Il filosofo Jonathan Birch identifica tre approcci al problema della coscienza degli insetti: “theory-heavy”, “theory-neutral” e “theory-light”. Ciascuno di questi metodi, pur partendo da presupposti diversi, arriva alla stessa conclusione: non possiamo escludere che gli insetti siano senzienti. Studi comportamentali mostrano che le api manifestano stati che assomigliano all’ottimismo o al pessimismo, a seconda delle esperienze pregresse. La questione non è più “se” gli insetti hanno esperienze soggettive, ma “quali” esperienze hanno e quanto sono intense.
L’evoluzione della sofferenza
E veniamo alla chiave che forse ci permette di aprire la porta al problema della coscienza e quindi della consapevolezza. Dal punto di vista evolutivo, il dolore ha una funzione adattativa chiara: fornire informazioni su minacce ambientali in modo motivazionalmente saliente. Questo vantaggio adattativo sarebbe particolarmente utile per animali mobili che affrontano ambienti complessi pieni di opportunità e minacce. Non esiste un motivo biologico convincente per cui questa capacità dovrebbe emergere improvvisamente nei vertebrati e non negli invertebrati più complessi. L’evoluzione non fa salti arbitrari, ma procede per gradualità: se il dolore è utile per noi, perché non dovrebbe esserlo per loro?
I nostri pregiudizi contro questa possibilità sembrano derivare più da fattori arbitrari che da considerazioni scientifiche. Se le formiche fossero grandi e rare come rinoceronti, probabilmente avremmo meno difficoltà ad attribuire loro esperienze soggettive. La dimensione, il numero e la familiarità con questi animali condizionano le nostre intuizioni morali più di quanto vorremmo ammettere. Un altro problema è la struttura stessa del nostro ragionamento: “gli insetti non contano; se provassero dolore, conterebbero; quindi non provano dolore” – un’argomentazione circolare che deriva conclusioni fattuali da premesse etiche falsate. È, insomma, decisamente comodo pensare che gli insetti siano vivi ma al tempo stesso non lo siano realmente perché (secondo noi) non provano dolore.
Il dilemma e la via della considerazione
Riconoscere la possibilità del dolore negli insetti non significa paralizzare le nostre azioni. Non stiamo suggerendo di lasciare che le zanzare diffondano malattie o che i parassiti distruggano i raccolti. Consideriamo già moralmente molti animali che utilizziamo per vari scopi legittimi. Il punto è: possiamo migliorare il modo in cui trattiamo gli insetti durante questi utilizzi? La nascente scienza del benessere degli insetti si pone proprio questo obiettivo: scoprire quali morti sono meno dolorose per loro, quali minacce subletali affrontano, come distinguere le sofferenze più gravi dalle meno gravi.
La scienza da sola non basta: è uno strumento che ci fornisce informazioni preziose per fare altro: pensare e fare delle scelte. Siamo all’inizio di un percorso di riflessione che promette di interrogare profondamente la nostro visione antropocentrica del mondo. La sfida non è eliminare ogni impatto sugli insetti (impresa impossibile) ma iniziare a considerarli come esseri capaci di sofferenza. David Foster Wallace concludeva il suo saggio sulle aragoste con un invito a prestare attenzione a ciò che accade nel nostro piatto. Oggi, quell’invito si estende a guardare con occhi nuovi ciò che accade sul nostro parabrezza, sotto la nostra ciabatta o nei campi spruzzati di pesticidi. Considera la mosca: non chiediamo altro.
Alcune fonti di questo articolo:
- https://arxiv.org/abs/2502.16088
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10234516/
- https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2022.0599
- https://www.newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/do-insects-feel-pain
- https://www.izsvenezie.it/insetti-cibo-futuro-rischi-alimentari-aspetti-nutrizionali/