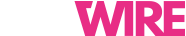Sarebbe fantastico riuscire a prevedere i terremoti, la loro intensità, i potenziali danni, salvando migliaia di vite. Invece no. Perché non si può, come ad esempio si può prevedere il meteo? Ci sono delle ragioni perfettamente razionali, legate sia alla natura dei terremoti che al livello di tecnologia che abbiamo a disposizione. Per capirle, però, prima è necessario capire cos’è un terremoto.
La terra trema
Un terremoto è un improvviso scuotimento della crosta terrestre causato dal rilascio di energia accumulata, che si manifesta con vibrazioni e onde sismiche. L’energia viene rilasciata a causa soprattutto dei movimenti delle placche tettoniche lungo le faglie, ma esistono anche altre cause naturali, come quelle vulcaniche o da crollo sotterraneo di porzioni della crosta terrestre.
La vibrazione si origina in un punto sotterraneo più o meno profondo, chiamato ipocentro, e si propaga fino alla superficie, dove si avverte maggiormente in quello che viene chiamato epicentro. Le oscillazioni del terreno hanno durata diversa: si va da terremoti che durano pochi secondi a quelli che durano anche alcuni minuti.
Che cos’è un terremoto
| Cos’è un Terremoto | Caratteristiche Principali | Scale per Misurarlo |
|---|---|---|
| Movimento improvviso della crosta terrestre dovuto alla rottura di rocce sottosuolo e rilascio di energia elastica accumulata nel tempo | – Origine nell’ipocentro (punto interno dove avviene la rottura) – Epicentro (punto in superficie sopra l’ipocentro) – Propagazione di onde sismiche (P, S e superficiali) – Può durare pochi secondi ma creare effetti estesi – Cause principali: movimenti tettonici, vulcanici, crolli o esplosioni | – Scala Richter (magnitudo): misura quantitativa dell’energia rilasciata, scala logaritmica – Scala Mercalli (intensità): misura qualitativa degli effetti sul territorio e persone, scala da I a XII – Magnitudo momento (Mw): versione moderna e più affidabile per grandi terremoti |
È l’arrivo nella zona di gruppi diversi di onde sismiche a determinare il tipo di terremoto: le onde sismiche possono essere longitudinali, trasversali, superficiali e provocano fenomeni di compressione e di dilatazione nel suolo che producono le vibrazioni che si avvertono sulla superficie.
Le scosse dei terremoti, a seconda della direzione rispetto al punto di osservazione, possono essere di tipo ondulatorio (vibrazioni in senso orizzontale) o sussultorio (vibrazioni in senso verticale). Di solito le scosse sono più di una.
La forza dei terremoti
Prima di prevederlo bisogna capire quanto è forte un terremoto. Come si fa a capirlo? Serve una scala di misurazione. Dal momento che i terremoti sono antichi quanto il nostro pianeta e che l’umanità ne ha fatto esperienza fin dall’inizio, le prime misurazioni fatte dai nostri antenati non potevano usare degli strumenti scientifici e non avevano a disposizione una teoria fisica che permettesse di misurare dei valori oggettivi.
Però l’essere umano è ingegnoso e ha sviluppato varie soluzioni molto intelligenti. La prima scala più diffusa per misurare i terremoti in tempi recenti è la scala Mercalli, prima da 10 e poi da 12 livelli, che misura in realtà i danni fatti a cose e persone.
Sviluppata tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, è molto utile perché consente di fare valutazioni semplicemente basate sull’osservazione degli effetti di un terremoto. Chiaramente non misura in maniera oggettiva il sisma, perché due terremoti uguali possono avere un grado Mercalli molto diverso a seconda dei danni che fanno. Tuttavia, la scala Mercalli permette ad esempio di comunicare la gravità di un terremoto in maniera molto più diretta, e anche di valutare e misurare, sulla base delle testimonianze storiche, i terremoti dell’antichità. Questo è fondamentale per cercare di costruire delle serie storiche sulle quali poi basare le analisi statistiche.
In tempi più recenti, con lo sviluppo sia della teoria fisica che degli strumenti di misurazione delle scosse (a partire dai primi sismografi), si hanno delle misure completamente diverse: si può misurare quantitativamente la magnitudo di un sisma, che fornisce una misurazione dell’energia liberata dal terremoto, guardando i sismogrammi e usando per calcolarla la scala Richter (degli anni Trenta del Novecento) oppure il suo aggiornamento, cioè la scala di Magnitudo del momento sismico (degli anni Settanta).

Pioggia o terremoto?
La fisica, la teoria della tettonica a zolle e la rappresentazione matematica dei terremoti sono molto complesse e per niente intuitive. Ma non è questo il motivo per cui non possiamo prevedere i terremoti come facciamo ad esempio con il meteo, nonostante nel mondo ci sia una fittissima rete di sismografi. Il problema infatti è un altro.
La ragione per cui non riusciamo a prevedere i sismi con l’accuratezza che caratterizza le previsioni meteorologiche risiede nel fatto che i fenomeni sismici si originano negli strati profondi della Terra, dove regnano temperature elevate e pressioni estreme che ne impediscono l’osservazione diretta.
Pur comprendendo i principi fondamentali del movimento delle placche tettoniche, risulta impossibile determinare in anticipo con esattezza il momento e il luogo di un evento tellurico a causa dell’irregolarità dei movimenti lungo le fratture crostali e della mancanza di segnali premonitori costanti e attendibili.
Ci sono anche altre strade abbastanza promettenti. Diversi studiosi stanno investigando potenziali indicatori anticipatori dei sismi, tra cui modifiche nella composizione chimica dell’ambiente (come le concentrazioni di radon), perturbazioni nel campo elettromagnetico, cambiamenti nella morfologia della superficie terrestre, sequenze di scosse di bassa intensità o alterazioni nel comportamento della fauna (gli animali che si innervosiscono, cani che abbaiano e gatti che scappano).
Ciononostante, questi fenomeni non offrono ancora garanzie di attendibilità e frequentemente vengono analizzati senza solide basi scientifiche: il consenso generale tra gli esperti è che attualmente non sia fattibile determinare con precisione quando avverrà un evento sismico, sebbene valga la pena continuare a indagare questi possibili indizi e perfezionare i modelli statistici utili alla gestione del pericolo sismico perché può aiutare a diminuire le conseguenze dei terremoti attraverso il potenziamento dei dispositivi di preallarme, della pianificazione dell’emergenza e delle misure preventive.
Previsioni meteo e sismiche
| Aspetto | Previsione Meteo | Previsione Terremoti |
|---|---|---|
| Dati disponibili | Ampia rete di sensori (satelliti, radar, stazioni) con aggiornamenti continui | Dati limitati, sensori sismici e geodetici localizzati, difficili da estendere in profondità |
| Processo fisico | Atmosfera studiata in tempo reale con modelli dinamici e condizioni variabili rapidamente | Processi tettonici profondi, complessi, non osservabili direttamente e lenti nel tempo |
| Prevedibilità | Previsioni dettagliate a breve termine (giorni) con alta accuratezza | Previsioni puntuali (data, luogo, magnitudo) impossibili al momento; si lavora su previsioni probabilistiche a medio-lungo termine |
| Modelli utilizzati | Modelli matematici numerici basati su fisica fluidodinamica e dati in tempo reale | Modelli statistici e fisici limitati; incertezza elevata; uso di dati storici e probabilità |
| Segnali precursori | Fenomeni osservabili e misurabili (es. pressione, temperatura) | Ricerca di precursori non affidabili; gas radon, deformazioni, anomalie elettromagnetiche non confermate |
| Obiettivo pratico | Prevenzione e gestione eventi meteorologici (allerta, evacuazioni) | Gestione rischio e preparazione, non previsione precisa per ora |
| Rischio di falso allarme e panico | Possibile ma generalmente basso, mitigato da continui aggiornamenti | Alto rischio, previsioni non certe possono generare allarmi ingiustificati |
| Tecnologia e sviluppo futuro | Continua evoluzione con più dati, AI e satelliti avanzati | Ricerche innovative ma con limiti strutturali; la predizione esatta resta una sfida enorme |
La meteorologia è più facile
E qui il confronto con il meteo diventa evidente. Infatti, per chiudere il parallelo, la meteorologia può contare su informazioni atmosferiche acquisite ininterrottamente attraverso tecnologie satellitari, sistemi radar e rilevatori aerei che permettono di seguire in diretta l’evoluzione rapida dei fenomeni atmosferici, mentre l’attività sismica deriva da trasformazioni geologiche che richiedono tempi lunghissimi e avvengono in zone inaccessibili al di sotto della superficie terrestre.
A ciò si aggiunge che ogni evento sismico risulta dalla combinazione non lineare di numerosi fattori locali interconnessi in modo complesso, impedendo così di stabilire l’istante preciso in cui si manifesterà una scossa tellurica.
Riusciremo mai a prevedere i terremoti?
Allo stato attuale, gli scienziati sono in grado solamente di elaborare stime probabilistiche utilizzando i dati storici dell’attività sismica regionale e modelli che calcolano le possibilità di eventi futuri su periodi temporali estesi.
La ricerca sta esplorando tecniche per aumentare l’affidabilità delle stime sul numero di terremoti previsti in determinate zone, tuttavia la previsione precisa di giorno e ora specifici rimane tuttora impossibile. Di conseguenza, l’approccio più efficace per minimizzare le conseguenze dei terremoti continua a essere quello della prevenzione mediante la mitigazione del rischio negli spazi abitati e nelle infrastrutture e la costruzione di strutture con criteri antisismici.
Alcune fonti di questo articolo:
- https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica/
- https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/terremoto/
- https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/terremoto/
- https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/science-earthquakes
- https://spaceplace.nasa.gov/earthquakes/en/
- https://www.bgs.ac.uk/discovering-geology/earth-hazards/earthquakes/
- https://www.britannica.com/science/earthquake-geology
- https://www.phivolcs.dost.gov.ph/introduction-to-earthquake/