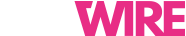Un giorno di questa estate un meteorologo alza gli occhi verso il cielo e poi consulta l’Atlante Internazionale delle Nuvole. Cirrocumulus a 7000 metri, cumulus humilis a 1200, copertura nuvolosa 6/8: la codifica è precisa, universale, comprensibile da Reykjavik a Singapore.
Torniamo indietro di vent’anni o poco più: nella sua casa di campagna inglese, David Mitchell osserva le stesse nuvole che corrono nel cielo e vi scorge le connessioni invisibili tra le vite umane, la danza eterna delle trasformazioni.
Ultimo salto, questa volta nella biblioteca della villa sulle colline di Firenze di uno dei più importanti esperti di Asia italiano, Fosco Maraini: alla sua vecchia scrivania di noce contempla una fotografia di nuvole tibetane e vi legge la poesia silenziosa del cielo.
Tre sguardi, una sola volta celeste, la stessa meraviglia: la scienza, la narrativa e la lirica che si incontrano nell’infinito teatro delle nubi. Con una sorpresa, alla fine (ma niente spoiler, non ancora perlomeno).
La precisione necessaria
L’Atlante Internazionale delle Nuvole nasce nel 1896 dalla necessità di dare ordine al caos meteorologico. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale, fondata nel 1950, trasforma quell’ambizione pionieristica in realtà globale: 193 Paesi membri che osservano il cielo con gli stessi occhi. Lo scopo è semplice: dare lo stesso nome alle stesse cose, per comunicare e quindi studiare e capire meglio il meteo.
La classificazione distingue 10 generi principali di nuvole: dai cirrus setosi a 12.000 metri di altezza agli stratocumulus compatti sotto i 2000 metri. Vengono codificati nell’Atlante per altezza, forma, struttura e trasparenza. È un sistema talmente potente e condiviso che ogni giorno, 15.000 stazioni meteorologiche nel mondo inviano 750.000 osservazioni attraverso il Global Telecommunication System, garantendo che un cumulus fotografato in Patagonia sia identificabile con la stessa precisione in Lapponia.
Il sistema di codifica internazionale come abbiamo detto trasforma le nuvole in linguaggio universale. E lo fa con una serie di sigle: Cc per i cirrocumulus, Ac per gli altocumulus, Ns per i nimbostratus. Gli osservatori addestrati secondo i criteri WMO riconoscono 27 specie, 14 varietà e 9 caratteristiche supplementari, creando un vocabolario di oltre 200 combinazioni possibili.
La versione digitale del 2017 include 6000 immagini ad alta risoluzione e video esplicativi, accessibili in sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Questo rigore scientifico non è fine a se stesso, come abbiamo visto: permette previsioni meteorologiche accurate, garantisce la sicurezza di quattro miliardi di passeggeri aerei annui e fornisce dati essenziali per monitorare i cambiamenti climatici.
Il cielo come metafora

Nel 2004, David Mitchell pubblica “Cloud Atlas“, romanzo che trasforma le nuvole da fenomeno meteorologico in simbolo letterario. Sei storie attraversano cinque secoli, dal 1850 al 2321, intrecciate come formazioni nuvolose che si addensano, si disperdono e si ricompongono in configurazioni sempre diverse.
Il titolo non è casuale: le nuvole rappresentano la natura mutevole dell’esistenza umana, l’eterno divenire delle forme che appaiono solide ma sono vapore in movimento. Mitchell costruisce una struttura narrativa “a matrioska” dove ogni storia contiene tracce delle altre, come le nuvole che si formano dall’evaporazione di acque lontane.
Il film dei fratelli/sorelle Wachowski e Tom Tykwer del 2012, con un budget di 173 milioni di dollari, trasferisce sullo schermo questa visione caleidoscopica. Gli stessi attori interpretano personaggi diversi attraverso le epoche, incarnando il tema delle connessioni invisibili che legano vite apparentemente separate. Le nuvole diventano elemento visivo ricorrente: dalla tempesta che minaccia la nave del 1850 ai cieli inquinati della Neo Seoul del 2144.
La critica ha spesso frainteso l’opera, cercando una trama lineare dove Mitchell offre invece una riflessione circolare sul tempo, dove ogni azione genera conseguenze che si propagano attraverso i secoli come onde nell’atmosfera. Così, per alcuni critici il film è un capolavoro come il libro, mentre per altri critici è solo un insieme caotico senza una vera storia.
Tuttavia, al pubblico piace tantissimo. Tanto che il successo internazionale, con oltre 3 milioni di copie vendute e traduzioni in 40 lingue, dimostra la potenza evocativa delle nuvole come metafora universale. Mitchell attinge alla tradizione romantica inglese che vede nel cielo uno specchio dell’anima, ma la contamina con elementi fantascientifici e filosofia orientale.
Le nuvole diventano così simbolo di impermanenza buddhista, del ciclo della reincarnazione e al tempo stesso di resistenza umana contro l’oppressione. È la letteratura che trasforma la meteorologia in cosmologia personale, dove ogni formazione nuvolosa racconta una storia di trasformazione e rinascita.
L’intimità del contemplare
Tuttavia, il fiorentino Fosco Maraini, orientalista e fotografo, nato nel 1912, pubblica negli anni Ottanta il suo piccolo “Atlante delle Nuvole“, gioiello editoriale che coniuga rigore scientifico e sensibilità poetica.
Figlio del pittore Antonio Maraini e padre della scrittrice Dacia, Fosco porta nell’osservazione del cielo l’esperienza di tre spedizioni in Tibet e la conoscenza profonda della cultura giapponese. Le sue fotografie catturano nuvole sui ghiacciai himalayani, sui templi di Kyoto, sulle coste siciliane: un diario visivo che attraversa 50 anni di viaggi.
I testi di Maraini che accompagnano le immagini alternano classificazioni scientifiche e riflessioni liriche, creando un’osmosi unica tra sapere occidentale e contemplazione orientale.
L’opera di Maraini misura appena 120 pagine ma condensa una filosofia dell’osservazione: le nuvole come paesaggio dell’anima, dove la precisione descrittiva non esclude l’emozione estetica. Le sue definizioni scientifiche si stemperano in metafore: i cirrostratus diventano “veli di seta tesa sul blu“, i cumulonimbus “torri di luce oscura cariche di elettricità“.
L’influenza della cultura giapponese emerge nella predilezione per gli spazi vuoti, i silenzi visivi, la bellezza dell’effimero. Ogni fotografia è accompagnata da coordinate geografiche precise e condizioni meteorologiche, ma anche da haiku improvvisati e citazioni di poeti orientali.

La tradizione italiana della letteratura naturalistica, da Leopardi a Calvino, trova in Maraini un interprete originale che unisce precisione illuministica e sensibilità ermetica. Le nuvole diventano pretesto per meditazioni sulla luce, il tempo, la memoria: “Ogni nuvola è un pensiero del cielo che prende forma e subito si dissolve“.
L’atlante di Maraini non aspira alla completezza scientifica dell’opera WMO né alla complessità narrativa di Mitchell, ma offre qualcosa di diverso: l’invito a una contemplazione attenta che trasforma l’osservazione meteorologica in esercizio spirituale. È la via italiana al sublime naturale, dove la descrizione precisa genera emozione profonda.
Tre sguardi, una verità
L’Atlante WMO cataloga 27 specie di nuvole attraverso parametri oggettivi, Mitchell ne intesse 6 storie attraverso 5 secoli, Maraini ne cattura l’essenza in 120 pagine di fotografie e meditazioni. Tre approcci che non si escludono ma si completano: la precisione scientifica che garantisce la sicurezza di milioni di voli, la narrativa che trova nelle nuvole una metafora dell’interconnessione universale, la poesia che trasforma l’osservazione in contemplazione.
Tutti e tre riconoscono nelle nuvole un fenomeno che trascende la semplice meteorologia per diventare specchio della condizione umana. La scienza offre gli strumenti per decifrare il linguaggio del cielo, la letteratura ne svela i significati simbolici, la poesia ne cattura la bellezza ineffabile.
Forse è proprio questa molteplicità di sguardi a rendere le nuvole così affascinanti: forme in perpetua trasformazione che sfuggono a ogni classificazione definitiva, accessibili a tutti ma comprensibili solo attraverso l’incrocio di saperi diversi.
Sotto lo stesso cielo, ogni osservatore coglie una verità parziale ma necessaria: il meteorologo la codifica, lo scrittore la racconta, il poeta la contempla. E in questa triangolazione di prospettive emerge forse l’unica certezza possibile: che la bellezza del mondo si rivela solo a chi sa guardare con occhi plurali, scientifici e poetici insieme.
| Aspetti | Atlante Internazionale WMO | Cloud Atlas (Mitchell) | Atlante di Fosco Maraini |
|---|---|---|---|
| Riferimento alle Nuvole | Classificazione scientifica e fotografica | Nuvole come metafora narrativa | Nuvole come soggetto visivo e poetico |
| Finalità | Standardizzazione e osservazione globale | Raccontare connessioni umane profonde | Contemplazione e documentazione naturale |
| Tipologia di contenuto | Immagini scientifiche, tabelle, definizioni | Testi letterari, storie intrecciate | Fotografie, testi poetici e naturalistici |
| Pubblico | Esperti, meteorologi, istituzioni | Lettori di narrativa e cinema | Amanti della natura e letteratura |
| Approccio | Oggettivo e tecnico | Simbolico e filosofico | Lirico e descrittivo |
La sorpresa animata
C’è infatti un quarto atlante delle nuvole che merita menzione: quello disegnato a mano da Hayao Miyazaki attraverso 40 anni di cinema d’animazione. Il fondatore dello Studio Ghibli ha fatto del cielo e del volo un’ossessione creativa, trasformando ogni pellicola in un trattato poetico di meteorologia animata.
Dai delicati cirrocumuli che accompagnano il volo di Nausicaä alle tempestose formazioni che nascondono il castello di Laputa, da quelle di “Conan il ragazzo del futuro” a quelle della piccola strega Kiki, le nuvole di Miyazaki sono protagoniste quanto i personaggi umani. Nei suoi lungometraggi e serie, il maestro giapponese ha creato una biodiversità aeronautica senza precedenti: immense corazzate volanti che solcano i cieli come cetacei, eleganti alianti ibridati con ali di insetto, dirigibili bimotore che sferragliano tra le nuvole.
Le sue nuvole non sono semplici sfondi ma spazi narrativi dove “si vola con la fantasia, con la magia o con la telecinesi“, dove ogni formazione nuvolosa racconta una storia di libertà e trasformazione. È un altro sguardo rivolto al cielo e alle nuvole che lo rendono davvero unico.
Alcune fonti di questo articolo:
- https://wmo.int/media/magazine-article/new-edition-of-international-cloud-atlas
- https://cloudatlas.wmo.int
- https://ams.confex.com/ams/96Annual/webprogram/Paper286260.html
- https://library.wmo.int/records/item/66297-manual-on-the-observation-of-clouds-and-other-meteors-international-cloud-atlas
- https://forumeteoclimat.com/en/wmo-the-new-international-cloud-atlas/
- https://wmo.int/news/media-centre/international-cloud-atlas-translated-official-un-languages
- https://www.rmets.org/event/new-international-cloud-atlas
- https://cloudatlas.wmo.int/definitions-of-clouds.html
- https://cloudatlas.wmo.int/introduction.html
- https://blogs.reading.ac.uk/wcd/2017/03/23/the-new-international-cloud-atlas/
- https://cloudatlas.wmo.int/preface-to-the-1939-edition.html
- https://wmo.int/world-meteorological-day-2017/classifying-clouds
- https://www.cma.gov.cn/en2014/news/News/201703/t20170323_402251.html
- https://cloudatlas.wmo.int/docs/wmo_407_en-v1.pdf
- https://cloudatlas.wmo.int/history-of-the-ICA.html
- https://cloudatlas.wmo.int/cloud-classification-summary.html